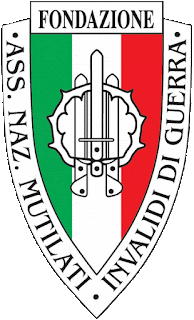(a cura di Daniele Vaienti)
Cesare Garaffoni,
1923,
Cesena, soldato ex I.M.I.
Cesena, 3 aprile 2008
(Testimonianza raccolta da Maurizio Balestra, revisionata da
Daniele Vaienti il 4 settembre 2012)
Mi chiamo Cesare Garaffoni, sono nato il 27 maggio del
1923. Prima di partire per la guerra abitavo nell'angolo di via Montalti, di
fronte alla casa di Bagioli. Prima ancora abitavo lì vicino, in via
Uberti, all’angolo con Via Sacchi. Ho giocato, da bambino, fra la piazzetta di
Palazzo Romagnoli e la
Piazzetta del Leone. Lì vicino c’era il Palazzo Urbinati,
quello della Società Elettrica e un negozio di generi alimentari. Io abitavo
sopra il negozio. La casa fu distrutta nei bombardamenti e quando tornai lì non
c'era più. Lì vicino c’erano delle osterie: una, dalla mia parte e una sul lato
opposto, quasi all’angolo con Via Uberti, l’Osteria “Da Davin”. Ho studiato
ragioneria e ho fatto il soldato qui a Cesena, facevo parte del 12° Reggimento
di Fanteria della Divisione Piemonte, che aveva sede a Messina, comandata dal
colonnello Pozzuoli, napoletano. Sono partito da Cesena nel febbraio del ‘43,
destinazione Grecia. Partiamo da qui. Arriviamo al Pireo, poi a Pyrgos e quindi
a Zante, che è il luogo dove è iniziato il mio calvario.
A Zante, dato
il mio titolo, vengo scelto per tenere la contabilità e lì apro il libro mastro
della contabilità del Reggimento, insieme ad un capitano di cui non ricordo il
nome. Tenevo anche il danaro del reggimento, custodito in una cassaforte. Solo
con la firma del capitano potevamo aprirla e fare i pagamenti.
A Zante siamo
rimasti diciamo… dal marzo 1943 al 29 settembre dello stesso anno. Di fatto
amministravo tutto il danaro, tutti i versamenti e tutti i pagamenti del
Reggimento, anche i pagamenti fatti agli operai di laggiù per i lavori di
costruzione dei bunker e delle casematte, per la sistemazione della difesa,
eccetera. Venivano sempre pagati da me, che ero l'amministratore del Reggimento
dell'isola, tant'è che quando io mi ammalai di malaria e di dengue[1], il
colonnello fece di tutto per aiutarmi. Racimolò tutto il chinino che si poteva
trovare. Perché se non fossi riuscito a rientrare entro sette giorni li si
sarebbe bloccato tutto. E dire che io non ero niente, ero un soldato semplice.
In queste condizioni siamo andati avanti fino all’8 settembre.
[Però la
voglio fermare un attimo, perché prima dell'8 settembre arriva il 25 luglio.
Voi non sapete niente di quanto accade?]
Ecco noi del
venticinque luglio non abbiamo avuto nessuna notizia, nessun riferimento,
nulla.
L'8 settembre
noi ricevemmo la notizia subito. Con una radio o in altro modo, io non so come,
non ricordo, ma la cosa si propagò immediatamente. Tutti i soldati andarono in
strada e si pensava “Abbiamo finito la guerra! Finisce la guerra, torniamo a
casa!”
Poi perdemmo
tutti i contatti con lo Stato Maggiore, non si seppe più nulla e a un certo
momento ci fu una riunione degli ufficiali perché a Zante c'erano circa
quaranta militari tedeschi e bisognava decidere cosa fare. Noi facemmo
prigionieri i militari tedeschi e li disarmammo; questo avvenne circa negli
otto-dieci giorni dopo l'8 settembre e loro si arresero senza sparare. A Zante,
a presidiare tutta l’isola c’erano alcune migliaia di italiani, forse seimila,
ma nel centro di Zante erano forse meno della metà. La mattina del 29 settembre
del 1943, in
lontananza, si vide arrivare un cacciatorpediniere con bandiera italiana, che
scortava una nave trasporto che pensavamo fosse italiana e tutti andammo giù al
porto, correndo e pensando: “Son venuti a prenderci, ci portano a casa.”. Questa era la voce che correva
nell’isola. Io mi fermai un po’ più in alto del porto e vedevo un tratto di
mare. Quando la nave arrivò in porto... ecco ho impresso nella memoria quello
che accadde e il luogo, come una specie di quadro che mi è rimasto impresso.
Qui avevamo la piazza Ugo Foscolo e qua, proprio davanti, c'era il mare. E qui
c'era il teatro, intestato a Foscolo anche lui, ed era diventato la sede della sussistenza,
con tutti i depositi delle cose da mangiare, i magazzini generali. La piazza
Ugo Foscolo confina col porto canale. Dalla piazza Ugo Foscolo si vede il
cacciatorpediniere che arriva a circa tre miglia e vira, va via, cambia rotta,
non entra. Continua a venire avanti, invece, la nave trasporto, arriva sul
porto si apre e scendono i carri armati tedeschi. Era stato tutto un trucco.
Arrivano i tedeschi e coi carri armati e si piazzano nel quadrato della piazza.
Le posizioni si fronteggiano e comincia uno scambio fra i nostri e i loro
comandanti: “Arrendetevi!” “No, arrendetevi voi!” Finché arrivarono gli Stukas
e fra quelli e i cannoni dei carri armati e la sorpresa, l'ultima decisione fu
quella di arrenderci, anche se noi avevamo dei cannoni. Si fece una la riunione
degli ufficiali presieduta dal colonnello Pozzuoli e si decise che ci
arrendevamo. Non fu sparato un colpo. C’era lì, davanti al mare, una specie di
grande palestra dove si raccolsero tutte le armi: ogni militare e sottufficiale
doveva deporre tutte le armi in questo luogo e noi lasciammo lì tutto e ci
disarmammo.
Nessuno reagì,
Non c'era la possibilità. Eravamo in un'isola, distante dalla terraferma e
senza niente, senza mezzi. Non si poteva scappare o lasciare l’isola, questa
era la situazione. Non c'era possibilità di nascondersi, non a Zante. E’ una
piccola isola e poi dove vai? Perché i greci, per quanto noi li abbiamo
conosciuti (e lì eravamo ben visti), non potevano aiutarci e avevano il terrore
dei tedeschi, quindi chi poteva aiutarci? A me non risulta che nessuno di noi
sia riuscito a scappare e quindi...
Lì ci fu un
primo fatto: un capitano, di cui non ricordo il nome, (che era il capitano
addetto, con me, all'amministrazione generale e che non capiva nulla di
contabilità, per cui ero io che dovevo seguire tutto) questo capitano si
schierò con i tedeschi e assieme a lui, lo fecero una quarantina di soldati che
erano tutti richiamati, con moglie e figli, siciliani, sulle migliaia che si
era. Lui fece anche un po' di propaganda in giro per passare con i tedeschi.
Dopo, quando la stessa nave da trasporto che aveva portato lì i carri armati,
ci caricò e ci trasportò fino al porto del Pireo, sapemmo che lui era rimasto
lì, a Zante. Devo anche dire che io avevo in gestione i soldi del reggimento.
Li depositavo in una banca, tenendo in cassaforte solo quello che mi serviva.
Prima dell’arrivo dei tedeschi avevo fatto un versamento e avevo una ricevuta
per tre milioni e rotti di dracme che avevo depositato. La ricevuta di quel
versamento l’ha voluta quel capitano e non so poi lui l’abbia consegnata ai
tedeschi che cercavano i soldi…[2]
Sbarcammo al
Pireo e dal porto, a piedi, con lo zaino in spalla, andammo ad accamparci fin
sull'Acropoli. Sì, proprio sull'Acropoli e li restammo non mi ricordo quanti
giorni. Per il mangiare dovevamo vivere con quello che avevamo portato nello
zaino.
[E anche lì
non ci fu nessuno che riuscì a scappare?]
Nessuno, anche
se di lì, forse, si poteva anche scappare. Si poteva scappare anche perché da
quel momento noi non eravamo strettamente sorvegliati e inquadrati. Ma in
quelle condizioni e con la voce che girava che ci avrebbero riportato in
Italia! Anche dopo, quando siamo partiti di lì, che ci hanno messo su dei treni
e i vagoni erano aperti, c'erano una decina di sentinelle tedesche: ne avevo
uno o due in testa al treno, uno due alla fine e gli altri tedeschi in un
vagone per conto loro e potevamo scappare, ma dicevano che si tornava in
Italia...
Qualcuno ha
tentato di fuggire, per andare con quelli di Tito, poi è rientrato perché se
non avevi le armi non ti prendevano. Così era successo e quelli che sono
tornati hanno detto: “è inutile che scappiamo perché con Tito ci vai se hai le
armi e le munizioni, se no ti mandano indietro.”.
[Questo accade
in Jugoslavia, ma in Grecia nessuno vi ha contattato?]
No. In Grecia
non ci ha contattato nessuno. Né noi lo abbiamo fatto. In Grecia non c'è stata
possibilità perché siamo rimasti lì solo pochi giorni, così, un po' sbandati.
Fummo caricati
in dei vagoni aperti. Si poteva scendere nelle fermate. Non c'erano i soldati a
controllare per farci tornare dentro, c'era la possibilità di scappare. “Ma
perché?”, dicevano che ci portavano in Italia. Loro avevano detto così, o
meglio la voce era che si andava in Italia e tutti erano abbastanza tranquilli.
E infatti riconoscevamo la strada, perché noi l'avevamo già fatta all'andata.
Era quella... almeno fino un certo punto.
Quando siamo
al bivio, vicino a Trieste, è notte, non si vede nulla, la maggior parte di noi
dormiva, eravamo tutti pigiati (non mi ricordo quanti fossimo, forse in
quaranta in un vagone); al mattino... le date io non le ricordo... al mattino
ci svegliamo a Linz. Sentiamo urla: “Achtung!”. Apriamo i vagoni, ci troviamo
circondati. Il treno è tutto circondato dai tedeschi con le mitragliatrici
tutte fissate attorno.
Un gruppo di
tedeschi entrava in ogni vagone a fare una perquisizione. Una volta perquisiti,
da quel momento, si chiudono i vagoni.
E poi
arriviamo. Siamo in aperta campagna. Non so dove fosse, ma era un posto molto
bello, perché c'erano degli abeti enormi. Era un centro di raccolta e
destinazione, lo Stalag IV B. Era fatto proprio così come siamo abituati a
vederlo, con tutte le torrette e il recinto di filo spinato, un campo, con
tutti i crismi del campo di concentramento. A quel punto tutti veniamo tosati a
zero, ci rasano sotto le ascelle e dappertutto con delle macchinette. Tutti a
zero. E ci fanno la disinfestazione. Poi ci fanno mettere sulla schiena un
triangolo rosso che significava kriegsgefangener, prigioniero di
guerra.
Lì arrivò un
tenente, un tenente colonnello mi pare, o un maggiore. Era siciliano. Siccome
la divisione Piemonte era di stanza a Messina molti erano siciliani. Venne
questo tipo, mi ricordo, eravamo tutti in fila e ancora avevamo il nostro zaino
ai piedi, tutti in fila in piedi, lui venne e disse: “Sono arrivati gli
americani, sono sbarcati in Sicilia, violentano tutte le nostre donne, fanno
razzia, ne stuprano, ne fan di tutti i colori, noi dobbiamo andare a difendere
le nostre donne, voi siciliani soprattutto! Noi siamo pronti a partire, chi è
d’accordo venga da questa parte, chi invece non è d’accordo rimanga fermo.”. Io
rimasi fermo.
[Ne passarono
molti?]
Ne passarono
una buona parte e la maggior parte erano siciliani. La maggior parte avrà anche
pensato: “Quando siamo là chi sa cosa...” Però c'andarono eh!
Ma furono due
i momenti in cui ci fecero questa proposta. Il primo direttamente a Zante, al
momento dello smistamento. Quel capitano che parlò in quel momento era fascista
e parlò da fascista, non parlò dello sbarco degli americani, anche perché non
ne sapeva niente. Quello che parlò nello Stalag IV B, invece, che era anche un superiore, disse la
frase che ho riferito. Parlò diverse volte e si raccomandava, si ripeteva anche
nelle cose che diceva.
Noi
continuammo a non andare.
Dopo ci fu lo
smistamento e partimmo per un campo della Ammoniacwerke, io vado a finire a
Merseburg, che confina con la
Turingia. Il campo era fra la cittadina e la Ammoniacwerke , che
era la più grande fabbrica chimica d'Europa e occupava un’area lunga, mi pare,
quattordici chilometri con una ferrovia interna e quattro stazioni: Leuna nord,
Leuna sud, Leuna est e Leuna Werke. Quattro stazioni e ognuna aveva quattro
binari, tutti interni. Lì si fabbricava la benzina sintetica. Dove lavoravo io,
lo stabilimento numero 820 si faceva la seta sintetica che usavano per i
paracadute.
Si controllava
il sistema chimico che produceva la sostanza, che poi veniva raccolta e si
solidificava. Si lavorava in grandi ambienti. Alcuni erano ad un piano
superiore e da lì la sostanza colava giù da una specie di imbuto e si
raccoglieva nel piano inferiore, dove ero io. C’erano manometri e rubinetti da
aprire e chiudere quando i livelli erano arrivati al punto giusto e il liquido,
che inizialmente era bianco, diventava rosso. Allora si faceva un urlo e di
sopra, dove lavoravano dei francesi, chiudevano. Si facevano dei turni continui
di dodici ore e in coppia con me c’era questo francese, di Parigi. Io andavo
avanti così facendo i miei turni. Questo
finché non arrivarono i bombardamenti.
Finché non
incominciarono a bombardare questa fabbrica io ho continuato a lavorare lì e
con me lavoravano anche i tedeschi. Si facevano i turni e a un certo punto
c’era un intervallo, avevano un intervallo nell’arco delle dodici ore di
lavoro, e nell’intervallo i tedeschi mangiavano. Anche noi avevamo
l’intervallo, solo che noi non mangiavamo perché non avevamo niente da
mangiare. Allora mi ricordo che c'era qualcuno che veniva vicino a me e qualche
volta mi hanno passato da mangiare. C’era una signora, un'anziana, che avrà
avuto una cinquantina d'anni e che ogni tanto mi dava un pezzo di pane. Un
giorno mi portò addirittura un filone, perché all'uscita non facevano sempre le
ispezioni. Una volta che questa donna mi da il pane, io lo nascondo qui sotto
la giacca. Quello che sorvegliava era vicino a me, me lo ricordo, era zoppo,
(poveretto, era giovane, era tornato dal fronte). Forse aveva visto che avevo
preso il pane e dice “Alt, che dobbiamo fare le perquisizioni!”. E allora dal
cenno che faccio lui capisce tutto, viene lì da me, mi dà una spinta e mi dice
di dargli il pane “E st'altra volta”, mi dice, “dammelo prima”. Poi, appena
usciti, mi fa un cenno e mi ridà il pane, passato il controllo. Questi uomini
che ci controllavano erano rientrati dal fronte feriti, forse per questo erano
più umani.
Qui successe
anche un altro episodio. Mi ero ferito a un piede e si era infettato. In
infermeria mi avevano tagliato l’ascesso e medicato alla meglio, prima di
rimandarmi a lavorare. Dalle baracche al capannone della fabbrica dove si
lavorava c’era da fare un lungo percorso a piedi. Il percorso costeggiava la
ferrovia interna, lungo un terrapieno dove mentre passavamo tutti in fila, i
ragazzi del luogo, tutti attorno, ci gridavano “Keine lost!” “Forbaiten”
“Italiener Fareda” “Vagabondi
italiani! Traditori!” “Non han voglia di lavorare gli italiani, traditori!”… Io
camminavo in fondo al gruppo, con zoccoli di legno e a causa della gamba ferita
ero rimasto indietro. La guardia tedesca, rientrata ferita dal fronte russo, mi
spingeva e mi urlava, spinto anche dalle grida dei ragazzi. Ad un certo punto
mi minaccia, mi butta contro una rete, prende il fucile… Io sono allo stremo,
non penso neanche più a morire, quasi vorrei far finire quel supplizio. Basta
una reazione e forse mi sparerebbe. Non so neppure io come e perché, ma mi
volto verso la guardia e mi apro i vestiti e gli offro il petto. Rimane
interdetto, si smonta, cala un grande silenzio tutt’intorno... Mi dà una botta
nella schiena e mi spinge avanti...
In quel
momento, non pensavo di poter morire, forse lo desideravo anche e feci quel
gesto.
[Questo è per
quanto riguarda il lavoro. E la vita nel campo com'era?]
La vita nel
campo... potrei dire molto lavoro e niente pane. Per il pane noi avevamo
costruito delle bilancine, perché il pane non veniva distribuito ad ognuno il
suo pezzo, (adesso, fra l'altro, non ricordo neanche la pezzatura precisa)...
[Davano un
pezzo di pane per ogni baracca?]
No, no, no...
La baracca era unica e poi avevamo delle specie di stanze a uno, due, tre,
quattro castelli e se, per esempio, eravamo sedici, davano il pane per sedici.
A filoni interi, per cui noi dovevamo dividerlo e doveva durare per tre giorni.
Il problema era dividerlo nel modo giusto. Allora insieme a me, ricordo che
c'era un ingegnere e un certo Farina, uno che aveva dei mulini su nel
Trevigiano, che poi è diventato anche presidente del Milan. Farina assieme
all’ingegnere presero un bastoncino e si il trovò il modo di fissarne uno
trasversale, con due “cosi” che
pendevano e con questa bilancia si pesava il pane. Così riuscivamo a fare pezzi
giusti.
Un'altra delle
condizioni in cui si viveva è questa: si facevano turni di lavoro di dodici
ore, ma fra il prima e il dopo, cioè il cammino di andata e di ritorno e i
momenti nei quali si doveva aspettare, alla fine c'erano poche ore per
riposarsi. Poi bisognava lavarsi qualcosa perché quello che avevi addosso era
tutto quello che avevi. Non ci han mai dato niente e così bisognava accomodare
i vestiti. C'è chi ci riusciva, perché era capace di cucire. C'era chi aveva
del filo, del cotone... Io non ero capace… non avevo niente… me a n’aveiva gnint... Mi aiutavano due
di Cesena che si chiamavano Trevisani Medante e Sama Guerrino e uno di San
Vittore, che non mi ricordo il nome.
[E oltre il pane cosa vi davano
ancora da mangiare?]
Ah!... una
sbobba, quando c'era. Ma una sbobba con niente, insulsa, non c'era niente:
barbabietole o carote... una gamella,
ma non c'era la sostanza...
[Mi diceva che a un certo punto
cominciano i bombardamenti...]
Allora, donca… i tedeschi avevano creato questa
grande fabbrica: la Ammoniacwerke ,
tutt'attorno alla fabbrica, anche a quattro-cinque chilometri avevano delle
bombole enormi che potevano emettere dei fumogeni che annuvolavano tutto e non
si vedeva più niente. Quando si sentivano “uuu” le sirene d'allarme,
venti-venticinque minuti prima, loro spargevano i fumogeni. C'era questo
preavviso e lì noi eravamo liberi di andare dove volevamo ma i bunker che
c'erano erano solo per i tedeschi. Noi potevamo spargerci in giro per i campi.
Venivano a bombardare tutti i giorni, anche due volte al giorno. Io correvo
come un diavolo, come gli altri, a volte mi trovavo anche solo, non con gente.
I francesi mi chiamavano, le diable
rouge, perché avevo una camicia rossa. Le bombe all’inizio arrivarono fuori
bersaglio, non lo colpivano o lo colpivano solo marginalmente. Ma dopo i primi
due o tre bombardamenti, fu un disastro. Si lavorava che poco o niente, noi
minavamo le macerie... per poter ricostruire le parti danneggiate. Dovevamo
scavare per terra per rifare le fondamenta. Mi ricordo che era talmente freddo
che la terra era dura, gelata. Noi avevamo dei bidoni da duecento litri che
contenevano la benzina. Li aprivamo e facevamo fuoco per ammorbidire il terreno
se no col piccone non riuscivamo a romperlo. Dovevamo fare così. Facevamo così
quasi tutti i giorni.
E andammo
avanti così, in continuazione finché finì la guerra.
Lì vicino
hanno bombardato anche con il fosforo. I bombardamenti al fosforo noi li
vedevamo a distanza. Poi si correva via. Mi ricordo che andavamo sul fiume
Saale. C'era una grotta, ci si infilava dentro e a volte, sentivamo l'aria che
spostavano e mi son trovato più di una volta a contatto con la parete.
Poi avviene
che io mi ammalo e seriamente, anche. Mi sono ammalato a Merseburg e in un
primo momento mi hanno portato in un'infermeria a Merseburg. Lì han detto “No.
Bisogna trasportarlo all'ospedale di Lipsia”. Insieme a me, di ammalati, ce
n'erano altri, anche di altre nazionalità. Ci hanno caricato e ci hanno portato
in un capannone. Ho pensato e mi sono detto “Guarda. Qui è dove hanno gassato
la gente”… Il capannone era così: di qua si entrava e di là si usciva. Aperto.
Qui c'era un ingresso e là un'uscita, in un angolo, qui, in pochi minuti
entravi, tutto nudo, perché prima venivi passato in una disinfezione. Poi loro
avevano un pennello grande che lo intingevano e lo passavano sotto le ascelle e
sotto, lì, nelle parti… e dappertutto. E poi in alto c'erano dei buchi così,
delle docce nel soffitto... e noi stavamo sotto… ci si lavava e ci si
disinfettava, perché anche quell’acqua aveva un disinfettante e poi uscivamo da
quell'altra parte. Questo fu per entrare all'ospedale.
All'ospedale,
mi han fatto delle cure, lì si mangiava anche, però non mi hanno trattenuto
molto, mi han fatto... delle punture. Dicevano che io ero malato ai polmoni…
quello l’ho capito. Ricordo che era verso la fine di novembre, i primi di
dicembre. Feci il Natale lì quell'anno. I francesi nell'ospedale fecero uno
spettacolo e cantarono e portarono da mangiare per tutti e per noi fu una gran
cosa... il Natale del '44... Io sono stato lì ventisei-ventisette giorni e il
primo dell'anno ero già a lavorare di nuovo, mi rimandarono nella stessa zona.
[A fare le
stesse cose?]
No, no, no...
Dopo ci liberarono... ci fu la liberazione, cioè noi... ci fu la trasformazione
in civili... sissignore, sissignore, ci fu la trasformazione.
[E questo quando avvenne?]
Non mi ricordo
se fosse prima o dopo Natale. Sai che adesso sono un po' indeciso se fosse
prima o dopo. An m'arcord gnenca pió[3].
[Ad un certo
punto, dunque, vi lasciarono liberi, quindi voi eravate meno pressati, meno
sorvegliati?]
Sì, non
avevamo più i tedeschi che ci badavano… con la storia dei bombardamenti, si
capisce. Si andava a lavorare e si ottenevano dei buoni… che se no come fai a
vivere senza i buoni? Non ci pagavano, ci davano dei buoni, dei buoni, che non
potevi prendere niente, però ne avevi bisogno per mangiare.
Poi verso
aprile ci fu la liberazione degli americani... Gli americani attraversarono il
Saale e andarono incontro ai russi che arrivavano dall’altra parte. Non ci
furono combattimenti. Noi non abbiamo sentito niente, non si è sparato un
colpo. Ci siamo svegliati al mattino siamo andati a vedere e c'erano queste
file di soldati nella strada principale. Erano loro, gli americani, in fila
indiana una da una parte della strada e una dall'altro lato, coi loro fucili in
spalla e andavano: noi non abbiamo visto nient'altro.
[In precedenza
avevate avuto notizie sulla loro avanzata?]
Noi si sapeva
già, sapevamo dov'erano e dove non erano, cosa facevano… I francesi, in
particolare, avevano i giornali che gli arrivavano. L’Eco di Nancy, lo ricordo
ancora, l’Eco di Nancy e dato che io
parlavo francese, allora riuscivo a capire… e poi venivano tutti gli altri da
me per sentire le notizie. Aspettavamo e sapevamo che erano in arrivo, perché
verso Lipsia c'erano già i russi.
[Quando
arrivarono vi siete presentati a loro?]
Assolutamente
no. No. Loro volevano altro, loro avevano un compito... I tedeschi erano
spariti, non c'erano più, non c'era più niente. E noi siamo rimasti lì.
[I
bombardamenti avevano distrutto tutto prima che arrivassero gli americani?]
Sì. Non la
città, ma la
Ammoniacwerke , la fabbrica, quella sì...
[I soldati
tedeschi erano scomparsi ma la gente del posto?]
La gente...
non c’erano giovani? Lì c'erano solo i vecchi, gli anziani, le donne, anche
loro con una fame tremenda, perché non avevano più niente.
Vicino al
campo c’erano dei punti dove loro, gli americani, avevano la roba e dove noi
abbiamo trovato marmellata e dei fusti, dei bidoni da venti litri, con la
farina e... Insomma portavamo via sta roba e si mangiava. Noi fummo rimpatriati
a giugno.
Gli americani
avevano proseguito. Erano andati via perché la guerra ancora non era ancora
finita. E noi abbiamo sgomberato tutto.
Un altro
episodio che mi ricordo è di un individuo che aveva trovato un coniglio, lo
ammazzò e lo fece bollire, prese un bidone, quelli da dieci litri o venti, non
ricordo, tipo quelli dell'Arrigoni e lo riempì d'acqua. Poi se lo mangiò tutto
e morì soffocato perché non era abituato a mangiare così tanto!
Anch'io lì
usavo questi bidoni. Con la farina facevamo un impasto, lo facevamo bollire e
si mangiava…
[E quanto
tempo siete rimasti lì?]
Io son
rientrato a giugno. Dopo Lipsia[4] e il
ricovero all'ospedale. Io e gli altri italiano aspettavamo. Io stavo male,
sputavo sangue e allora andai da un medico privato e gli dissi: “Io non la
posso pagare, perché sono...” lui mi disse “No, non si preoccupi…”. E’ visiteva tot. Era un tedesco, un
anziano, avrà avuto settanta–ottant’anni... Io di tedesco qualcosa capivo e lui
mi dice: “Quando in Italia... Sanatorio” um
dis. E allora mi fa un certificato. “Questo certificato per quando arrivi”
dice. Si organizza un treno per il rientro, un treno ospedale. Io ho una gran
fretta di arrivare a casa mia e quando sono a Verona, taglio la corda e mi
metto sulla strada che porta giù, verso Modena e Bologna. Parte di lì un camion
carico di sacchi di grano, io salgo su questo camion didietro. Sopra eravamo in
diversi e questo camion ci porta fino a Modena. A Modena lui si ferma e ci
scarica. Mi faccio portare sulla via Emilia per vedere di andare a Bologna e
trovo nella strada uno di quei camion che aveva delle panche a sinistra e a
destra… Si poteva salire... io salgo e viene uno che vuole i soldi perché
bisognava pagare. Allora gli dico: “Vedi come son messo, vengo dalla Germania,
dalla prigionia, non ho una lira, mi dica come si chiama che glieli manderò.
Come faccio io a dargli i soldi?”. Lui dice di no, poi comincia a far casino e
allora c'è una signora lì di fianco che dice: ”Lasci stare, lasci stare, che
per lui pago io”. Questa signora pagò per me e io arrivai a Bologna. A Bologna
prendo vado in stazione, prendo il treno, un treno merci dove ci sono delle
assi come sedili, insieme a delle suore che dovevano andare a Gambettola. Mi
dicono” Andiamo a Gambettola però non sappiamo quando scendere]..” “Non vi
preoccupate perché io scendo a Cesena e voi, alla stazione successiva
scendete.” Alla stazione, appena sceso la prima persona che incontro è Venturi,
il capostazione, che abitava vicino, nella casa prima della mia ed eravamo
amici. Mi viene incontro e mi dice: “Lo sai? Tuo babbo è morto... e la tua casa
è stata distrutta, non abiti più lì.” Questo è il primo incontro...
Mio padre è
morto su a Celincordia il 18 ottobre[5], i
tedeschi gli han sparato nella schiena e la ferita fu tamponata dagli inglesi,
perché era aperta ... Gli inglesi l'hanno soccorso. Si chiamava Paolo. A
Celincordia, dove erano sfollati, lui aveva messo la famiglia dentro al
rifugio. Lui, all’imboccatura del rifugio, aveva fatto una specie di nicchia
dove faceva da mangiare, che non si poteva far da mangiare fuori. Non si sa se
i tedeschi lo abbiano preso. Forse hanno pensato che facesse dei segnali…
Oppure è stata una granata. Chi lo sa? Qualche cosa è successo… Fatto sta che
gli si è aperta la schiena ed è rimasto lì. C'erano gli inglesi sono arrivati e
subito l'han tamponato... Comunque lui è morto lì. Era il 18 ottobre del ’44.
Io, invece, son tornato meno di un anno dopo... era il giugno del 1945.
Cesare
è deceduto a Cesena il giorno 4 gennaio 2017
[1] La febbre
dengue, più conosciuta semplicemente come dengue, è una malattia
infettiva tropicale causata dal virus Dengue. Si presenta con febbre,
cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre al caratteristico rash simile a
quello del morbillo. In una piccola percentuale dei casi si sviluppa una febbre
emorragica pericolosa per la vita, con trombocitopenia,
emorragie e perdita di
liquidi, che può evolvere in shock circolatorio e morte. La malattia è trasmessa da zanzare del
genere Aedes, in particolar modo la specie aegypti. – Da
Wikipedia (http://it.wikipedia.org/wiki/Dengue)
[2] “Molti
anni dopo sono ritornato a Zante insieme a mia moglie e a Renato Antoniacci, il
titolare della ditta di autotrasporti e per curiosità, abbiamo cercato quella
banca. Ma il 12 agosto del 1953 c’era stato un terremoto ed era stata
distrutta.”
[3] In
realtà il cambiamento di status da Internati militari a liberi lavoratori,
avvenne nell’estate del 44. La confusione è probabilmente determinata dal fatto
che questo cambiamento non comportò nella realtà un effettivo progresso delle
condizioni di vita dei prigionieri, mentre per loro le cose cambiarono
effettivamente, con l’arrivo dei bombardamenti alleati. I bombardamenti oltre
agli edifici, riuscirono a disgregare alche la capillare organizzazione tedesca
e da questo momento si sentirono e furono effettivamente più liberi, si veda il
sistema dei “buoni” di cui parlerà più sotto, adottato nell’inverno ’44-’45.
[4] Lipsia è occupata dalle
truppe corazzate americane il 18 aprile 1945.
[5] Nei giorni in cui si
combatteva per Cesena, liberata il 20
ottobre 1944.